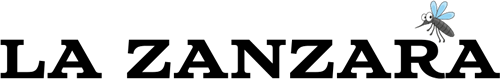|
Clicca qui per ASCOLTARE la lettura dell
Getting your Trinity Audio player ready...
|
UBI LEX NON DISTINGUIT, NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS. “Quando la legge non distingue, neanche noi dobbiamo farlo”.
Nel florido palcoscenico morfologico dell’ordinamento giuridico statale, intriso di antinomie e contrasti, che deve scontrarsi con la primaute’ comunitaria, si inseriscono una serie di distinguo puramente teorici destinati ad affollare l’aula delle discussioni infeconde. L’ opera di studio ed analisi del dato positivo seppur meritoria, in quanto chiamata a sciogliere i nodi del groviglio di disposizioni di legge che attraversano l’ordinamento giudiziario, stretti in una ipertrofica produzione normativa e che ha fatto parlare ad alcuni di una “bulimia legislativa”,risulta, a volte, ridondante e ampollosa. In un’ottica trasversale, si è passato in rassegna l’intero sistema normativo, alla ricerca di quelle elaborazioni dottrinali o accademiche che occupano spazi rilevanti nella struttura degli istituti ma che risultano di scarso, o talvolta di nessun, pregio giuridico.
1.VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE
Il provvedimento amministrativo, manifestazione di volontà della P.A. tesa al perseguimento dell’interesse pubblico e diretta a produrre autoritativamente effetti giuridici, è illegittimo(dunque annullabile) se viziato da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. Seppur di immediato rilievo teorico, si è dibattuto per anni relativamente alla individuazione pratica dei casi di violazione di legge ed eccesso di potere. La controversa figura dell’ excés de pouvoir, la cui elaborazione primigenia ed aurorale trae l’abbrivio dalla teorica d’oltralpe, è stata ricondotta dapprima ai soli casi di “sviamento di potere”, quindi a quelli di “straripamento di potere”, per poi ritagliarne l’ambito nel più generico “vizio di discrezionalità amministrativa” con non pochi dubbi relativamente ai casi di discrezionalità tecnica e ai provvedimenti non completamente vincolati(che residuino uno spazio di opinabilita’ da parte della P. A., breviter). L’ actio finium regundorum con la viciniore figura della violazione di legge ha indotto la dottrina ad una lunga e faticosa lista di figure sintomatiche dell’eccesso di potere che potesse dissolvere le ceneri della conclamata similitudine tra i 2 istituti. Rientrano (rectius: rientrerebbero) tra i casi di eccesso di potere le ipotesi di: “travisamento dei fatti”, “ingiustizia manifesta”, “violazione di circolari”, “disparità di trattamento”, “contraddittorietà e illogicita’ della motivazione”, “sviamento di potere “… Per anni, si è dibattuto(e si dibatte ancora) se tali figure ritaglino il vizio di violazione di legge o siano espressione di un eccesso di potere. Neppure l’avvento della legge sul procedimento amministrativo, la L. 241/1990, ha contribuito a sciogliere le riserve se non relativamente all’ipotesi di “difetto di motivazione” che, codificata nell’ art. 3 costituisce, dalla sua entrata in vigore in poi, un sicuro approdo per i casi di violazione di legge. Nelle restanti ipotesi regna sovrana l’incertezza sistematica della corretta collocazione delle figure sintomatiche. Cui prodest ? Il rilevato distinguo è privo di ogni rilevanza pratica ed ha precipitati applicativi di nessun conto. Ricondurre una determinata figura, nell’una o nell’altra ipotesi di illegittimità dell’atto amministrativo (o del provvedimento: atto conclusivo dell’iter procedimentale) porterà, in tutti e due i casi, all’annullamento dell’atto. Non vi è alcuna differenza sostanziale. Stante la copiosita’ della casistica e la complessità della rilevazione, si ritiene auspicabile un ridimensionamento del dibattito dottrinale.
2 L’ADDEBITO DI RESPONSABILITÀ NEL REATO ABERRANTE.
L’errore, in ambito penale, ha natura proteiforme:può incidere sul processo formativo della volontà (c.d. Errore-motivo art 47-49 c.p.), può riguardare la persona dell’offeso (Error in persona art. 60c.p.), può disciplinare i casi in cui la volontà si forma correttamente e la divergenza tra voluto e realizzato è dovuta ad un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione (c.d. Errore inabilità art 82 e 83 c.p.). L’art 83 c.p., per ciò che interessa ai fini della presente trattazione, prevede che il colpevole è chiamato a rispondere, per l’evento non voluto, “a titolo di colpa”. Dirimente è la funzione di tale sintagma : ci si chiede se sia stato inserito ai soli fini del trattamento sanzionatorio(quoad poenam) o se, invece, si richieda un concreto accertamento della colpa e dei suoi requisiti. La dottrina dominante propende per la prima soluzione e configura l’ aberratio delicti come una ipotesi di responsabilità oggettiva (secondo il noto brocardo del “qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu”). Tuttavia a seguito delle note Sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 della Corte costituzionale, pare non vi sia più spazio per una responsabilità senza colpa e che si opti per una lettura della norma conforme al principio costituzionale di cui all’art. 27 Cost, richiedendo, dunque, che l’evento non voluto sia imputabile almeno a titolo di colpa,se non di dolo. Si sono a questo punto succedute altre 2 tesi :quella della colpa generica e quella della colpa specifica. La prima reca con sé l’obiezione secondo cui il legislatore non può disporre un precetto che inviti il reo ad usare l’opportuna diligenza per evitare ulteriori conseguenze dalla perpetrazione di un reato doloso ( per intenderci, il precetto, stravagante e bizzarro, suonerebbe pressappoco così : “se proprio vuoi attingere alla vita di un soggetto con un colpo di arma da fuoco fallo, ma per lo meno usa l’ordinaria diligenza, quella dell’ homo eiusdem professionis ac condicionis; non essere imprudente ed evita di recare danno anche ad un altro soggetto ! “. Ipotesi inaccettabile da un ordinamento giuridico volto alla concretizzazione di precetti di moralità di matrice per lo più cristiana e votati al buonsenso. La seconda teoria, che vedrebbe insita in ogni norma penale una finalità cautelare, non fa, invece, i conti con quelle disposizioni incriminatrici di natura solamente punitiva e sanzionatoria(ex plurimis, il reato di omicidio che punisce colui che cagioni la morte di un uomo, senza enunciare alcun precetto programmatico di comportamento virtuoso da tenere, se non la stigmatizzazione della condotta descritta). L’elemento che accomuna queste 3 ipotesi(cui potrebbe aggiungersi la disputa sulla prevedibilità in astratto e sulla prevedibilità in concreto dell’evento non voluto), è che il colpevole risponde, in ogni caso, a titolo di colpa. Non ha alcun rilievo applicativo l’imputazione di una delle ipotesi testé descritte in luogo di un ‘altra: l’ elemento soggettivo resta quello della colpa. Ai fini del trattamento sanzionatorio il colpevole, per l’evento non voluto,vedrà irrogata una pena rientrante nel medesimo spazio edittale. Il dibattito sorto non ha dunque alcun rilievo se non puramente accademico.
3. LA CONTROVERSA FIGURA DELL’INESISTENZA DELL’ATTO.
La patologia dell’atto(civile e amministrativo) comprende le 2 figure della nullità e dell’annullabilità’. La nullità costituisce la regola generale di invalidità nel diritto civile, a differenza del diritto amministrativo dove la regola è l’annullabilita’. Accanto alla categoria dell’invalidità si pone la figura dell’inesistenza, la cui elaborazione aurorale affonda le radici nella dottrina francese in materia di nullità matrimoniali. Secondo una vetusta dottrina(degli anni ’30 del ‘900) l’inesistenza non costituisce una categoria giuridica autonoma, ma si confonde con la nullità. Tale elaborazione dogmatica trae l’abbrivio dall’idea che così come il negozio nullo è improduttivo di effetti e si considera tamquam non esset, così il negozio inesistente si fonderebbe sulla medesima ratio e ritaglierebbe i medesimi effetti giuridici. Sarebbe dunque privo di rilievo giuridico il dibattito sotto tra le due categorie di invalidità dell’atto, tanto civile quanto amministrativo, stante la medesima applicazione ed efficacia. A suffragare ulteriormente questa ricostruzione vi è l’assenza di alcun addentellato normativo relativo all’inesistenza, il che fa ritenere che tale controversa figura vada inglobata in una delle categorie codificate, nella specie quella della nullità, perché laddove il legislatore avesse voluto creare una autonoma fattispecie di invalidità avrebbe dedicato una sezione alla sua disciplina e configurazione ( come dicevano i giuristi giustinianei “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”). Si ritiene, dunque, priva di rilievo la distinzione tra nullità e inesistenza :una defatigante ricostruzione di 2 categorie le cui differenze e peculiarità si perdono nella concreta produzione dei medesimi effetti. Tra i fautori di tale dogmatica(a dire il vero, minoritaria) vi sono eminenti giuristi del calibro di Carnelutti, Fedele, Rubino. I detrattori di tale qualificazione obiettano che la nullità avrebbe, a differenza dell’ inesistenza quella “impalcatura esterna” (Barbero) che suscita un diverso interesse dell’ordinamento; precipitato immediato è l’applicazione di istituti volti alla reviviscenza dell’atto viziato da tale patologia, quali la conversione dell’atto nullo ed il principio di conservazione dell’ atto. In realtà, nella pratica, oltre al dibattito sulla autonomia dell’inesistenza vi è la concreta difficoltà nel rilevare quando si configura quest’ultima e quando la nullità : si pensi paradigmaticamente al caso dell’usurpatore di pubbliche funzioni che adotta un provvedimento in assenza dell’apposita investitura: pone in essere un atto nullo o inesistente?. O ancora l ‘atto adottato in carenza di potere :quale delle 2 ipotesi configura? Persin anche nelle ipotesi granitiche di inesistenza, quali la abnormita’ dell’atto adottato ioci o docendi causa, risulta complicato caratterizzarne i tratti distintivi e la linea di confine con la affine figura della nullità. Sembra, dunque, che l’intero dibattito possa essere sopito eliminando la distinzione e ricomprendendo le diverse figure in un’unica categoria.
4. LA GIURISDIZIONALIZZAZIONE DELL’ ABUSO DEL DIRITTO.
“Qui suo iure utitur, neminem laedit”. Il concetto di “diritto” e quello di “abuso” recano, ontologicamente, una contraddizione in termini. Il limite spaziale entro cui si muove un diritto non può mai costituire un abuso. L’idea di indagare sulla moralità del diritto porta con sé il rischio di confondere l’etica con il precetto giuridico. Si pensi, ad esempio, al noto caso del “frazionamento artato del credito” :costituisce abuso del diritto il comportamento ingiustificatamente vessatorio del creditore che frazioni la sua pretesa unitaria,nei confronti del debitore di una obbligazione pecuniaria “con il solo fine di rendere più complessa e gravosa la difesa del convenuto” (Cass. ss.uu. 2007). Il dibattito dottrinale che ne è seguito ha richiesto, a gran voce, la codificazione dell’istituto de quo agitur, ritenendo troppo fragile e irrisorio l’unico addentellato normativo costituito dalla norma sugli “atti di emulazione” disciplinata all’art. 833 c.c. Seppur teoricamente sarebbe lodevole uno sforzo legislativo in tal senso, tuttavia ritagliare i contorni di un istituto sfuggente come quello dell’abuso del diritto avrebbe il risultato opposto di delimitarne l’ambito al rilievo tassativo espresso dalla norma. Con maggior impegno esplicativo, sarebbe impossibile descrivere le innumerevoli forme di utilizzo distorto del diritto in una sola fattispecie, finendo per limitarne la portata. L’indirizzo predominante sovranazionale, in realtà, esalta i precetti enunciati dal “diritto vivente” (quello sancito dalle pronunce delle Corti) e rinnega il tentativo di “giurisdizionalizzazione” di istituti riconosciuti e valorizzati dalla prassi, negando valore all’inutile dibattito accademico su una loro positivizzazione. Così risulta priva di rilievo giuridico la disputa sulla codificazione dell’abuso del diritto, non perché sia argomento di scarsa portata applicativa, quanto perché il diritto è costruito in funzione degli uomini( cum igitur homimum causa omne ius constitutum sit, Ermogeniano), e per l’utilità sociale che riveste tale istituto risulta meglio tutelata la sfera soggettiva dei consociati tramite un principio che ricalca quello di solidarietà sociale e correttezza,costituente una valvola di sfogo del sistema di carattere poietico, che la tassativa norma oppressiva e dai contorni limitati.
AVV. MAURO CASILLO